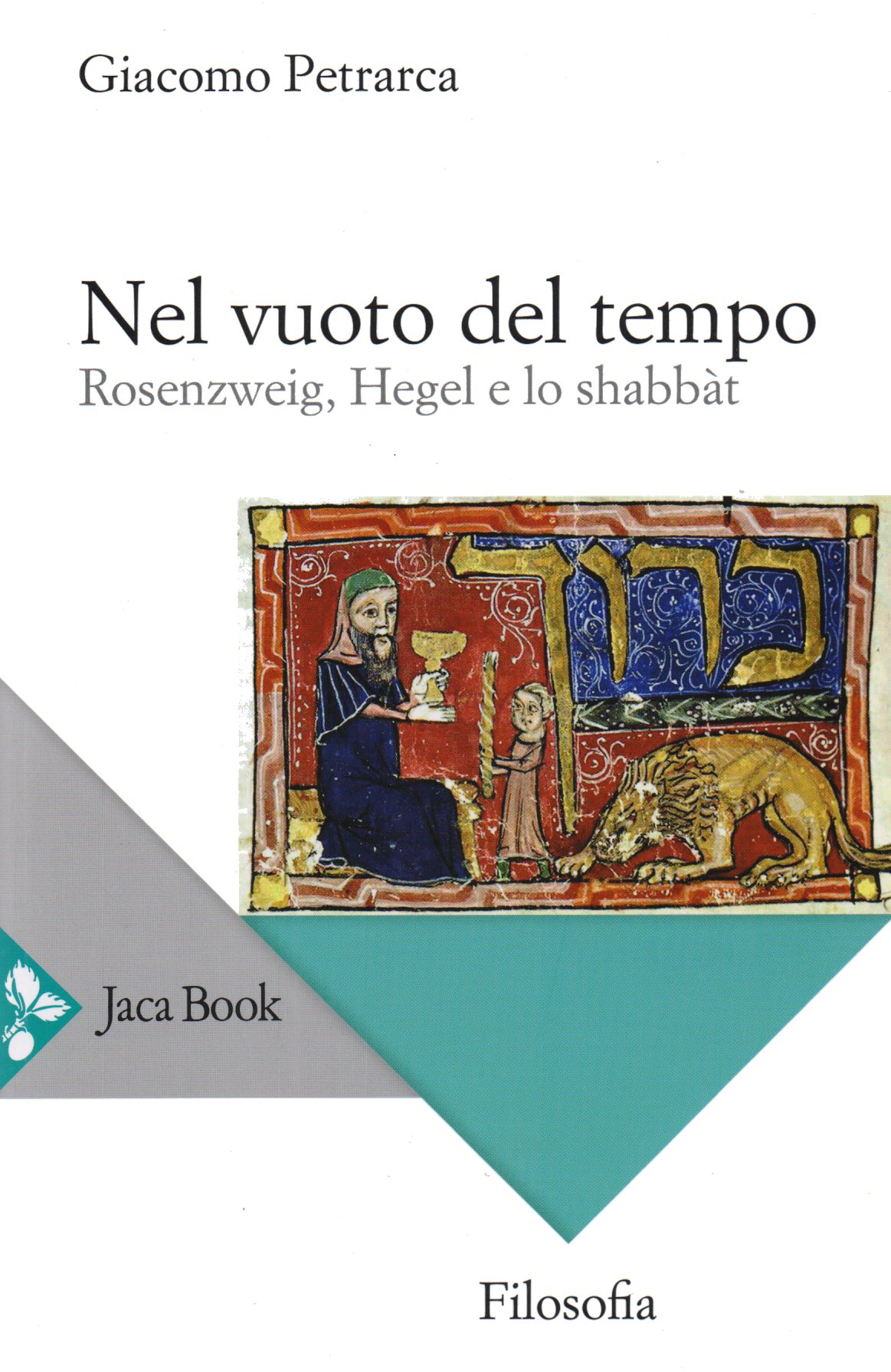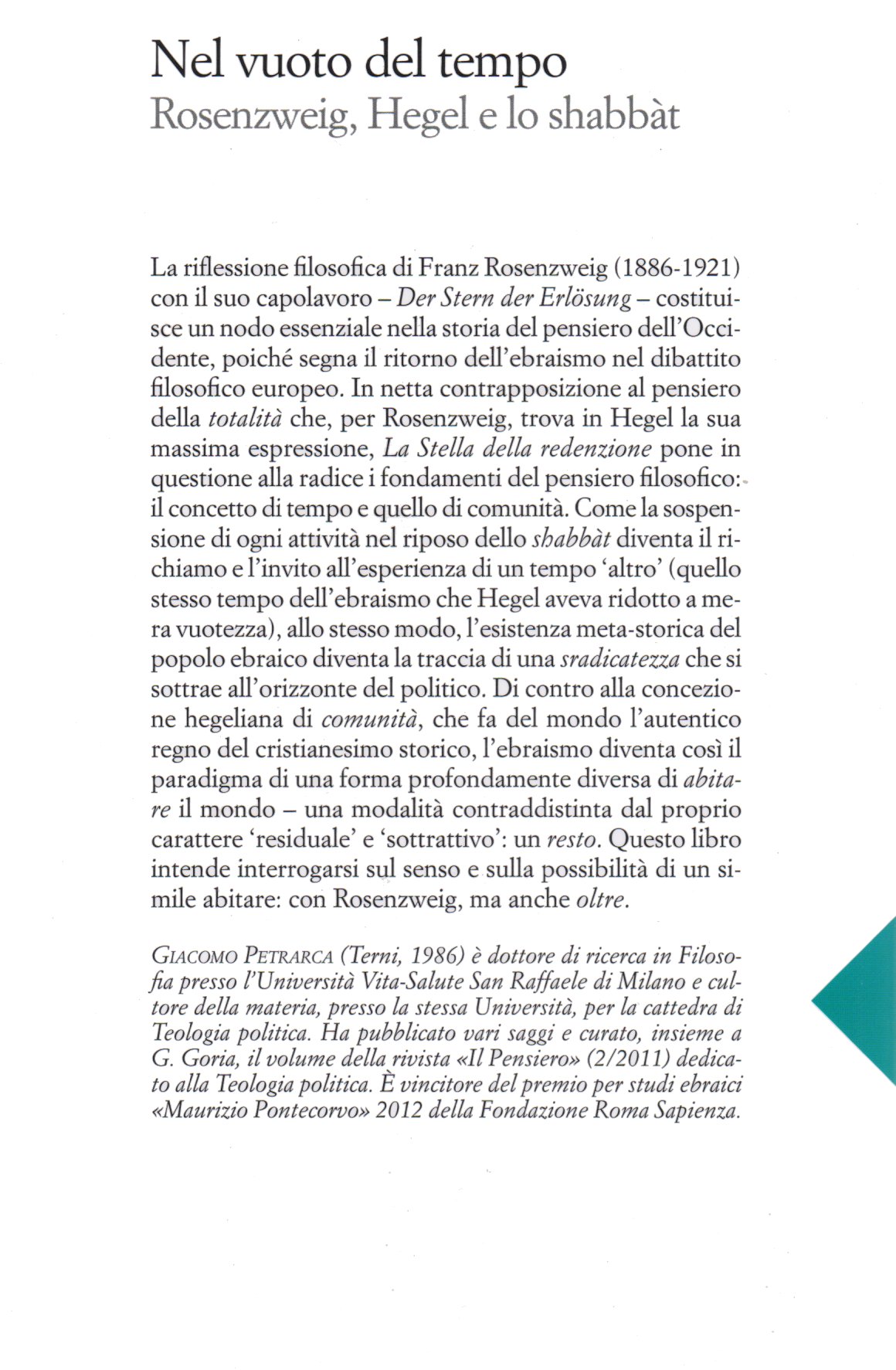Recensioni
Nel vuoto del tempo. Rosenzweig, Hegel e lo shabbàt
| Autore | Giacomo Petrarca |
| Genere | saggio |
| Area | Attività Scientifica |
| Casa editrice | Jaca Book |
| Anno | 2015 |
| Biblioteca | Visualizza la scheda del libro |
Quando inizia il declino della filosofia hegeliana, si afferma una nuova interpretazione delle categorie ebraiche, delle quali si sottolinea l'aspetto particolaristico in opposizione alla pretesa universalistica del filosofo di Stoccarda. Grande protagonista di questa operazione culturale è Franz Rosenzweig, e qui pare ancora inserirsi lo studio di Giacomo Petrarca, allievo di Vincenzo Vitiello, che col maestro prosegue un durissimo corpo a corpo con la filosofia hegeliana, attraverso questo approfondito ed acuto studio dedicato aDer Stern der Erlosung; "Fin dalle primissime pagine Der Stern der Erlosung s'apre con l'indicazione di un fatto: il 'venir meno' della totalità hegeliana. Di questo tramonto - che resta in quanto tale un fatto - Der Stern costituisce l'accertamento, ossia l'indicazione 'tipologica'; il tramonto della totalità hegeliana assume pertanto un duplice significato: per un verso, esso rappresenta il tòpos in cui Der Stern può sorgere, può cioè 'trovare' lo spazio per costituirsi, e per altro indica l'istanza di fronte alla quale Der Stern è posta, ovvero ciò di cui l'operazione filosofica di Rosenzweig deve farsi carico." (pp. 21-22). Petrarca va diretto al cuore del problema: la critica alla visione totalizzante di Hegel deve sfociare nell'elaborazione di un pensiero 'altro', in grado di sottrarsi ad ogni pretesa universalistica senza abdicare alla necessità di proporsi come fondamento per un nuovo modello politico. Un politico, che non è più politico, ma che resta politico. Per usare un linguaggio meno paradossale, la rivalutazione del particolare in contrapposizione all'universale hegeliano deve evitare il rischio stirneriano di una chiusura solipsistica nella singolarità (o 'Unicità', direbbe Stirner stesso). Così, se per Kierkegaard, che rimane il principale protagonista dell'operazione post-hegeliana, la soluzione è la rivalutazione della coscienza individuale, che deve assumere su di sé l'intera drammaticità della vita senza rifugiarsi in pretesi destini della storia, per Rosenzweig è l'immagine di una nuova comunità: 'am Israel, il popolo ebraico: Ed è proprio qui - cioè, nel luogo dell'opposizione a Hegel - che si palesa, di nuovo, la profondissima distanza tra Rosenzweig e Kierkegaard. Il volto del Danese è, infatti, essenzialmente volto a sciogliere il singolo dal vincolo comunitario (...) Per Rosenzweig, l'ab- solutezza del rapporto si chiama 'am Israel - l'assemblea di Israele, non il singolo ebreo, ché Israele è sempre e solo una comunità, o meglio, 'am, 'popolo', bené Israel, 'figli di Israele' (p. 84). L'autore della Stella, e, noi diremmo, con lui Petrarca, fa leva sulle categorie ebraiche per indicare questo nuovo modello comunitario dove il singolo non è inghiottito dalla totalità e la totalità non è ridotta a somma delle singolarità. La realizzazione del regno coincide con l'abitare una soglia, un limite, che nessuno come la sapienza ebraica ha saputo tematizzare. Soglia che si realizza nel tempo della preghiera, della festa, nella temporalità sospesa dello Shabbàt; che si realizza evitando il rischio del "peccatore" e del "visionario", i quali eccedono la soglia o per difetto, o per eccesso (p. 63). Ma, "v'è una tirannia più grande di quella del peccatore e del visionario, ché per un verso le invera nel loro intento dispotico (...) Tirannia che decreta non solo l'avvento del Regno, ma la reale (wirklich) poiché effettiva e operante presenzialità della basileia thou Theou. 'Il mio regno non è di questo mondo' - declama la voce del Tiranno dei tiranni: certo, ché se fosse solo mondano, altro non sarebbe che una regione di quello; ma un simile tiranno non è disposto a spartire i propri confini con altri regni, non guerreggia contro eserciti che sono già stati soggiogati al proprio dominio, né il suo regno conosce frontiere, ché al di là d'ogni confine e d'ogni limite vige ancora il proprio impero, la propria potestà, il proprio incondizionato nòmos." (p. 66). Ancora una volta una soglia, una contraddizione su cui bisogna stare. Contra la visione totalizzante di Hegel, l'ebraismo può insegnare una nuova forma dell'abitare il mondo, caratterizzata da un ritrarsi, che ricorda lo Tzimtzum con cui Dio retrocede per lasciare spazio al mondo. Un abitare, dice l'autore, che è residuale e sotrattivo, in una parola: resto. Giacomo Petrarca arricchisce il proprio studio con una conoscenza approfondita del commento ebraico, spesso letto con grande intuito interpretativo, dando ulteriore spessore ad un libro che nobilita il pensiero ponendolo a contatto con le grandi domande della tradizione e istituendo un confronto con autori decisivi come Hegel (su tutti), Schelling, Kierkegaard, Jabes, Celan, collocandosi, a livello teoretico, in un ambito che ha rappresentato una via attraverso cui l'Occidente ha ripensato la relazione con la propria radice ebraica, spesso vista come una pulsione particolarista, in contrasto con i ben più nobili ideali universalistici di matrice cristiana. Ed è proprio qui, a nostro giudizio, il punto dolente su cui bisognerebbe dibattere con l'autore: la visione dell'ebraismo come particolare da contrapporre all'Universale, non è ancora un modo di sottometterlo al cristianesimo? Ci sembra, attraverso questa domanda, di radicalizzare un'istanza sottolineata dallo stesso autore, nel commentare il ripensamento di Rosenzweig riguardo la propria conversione al cristianesimo: "La frattura ch'egli apre tra ebraismo e cristianesimo, è volta anzitutto a togliere ogni nesso di dipendenza dell'ebraismo nei confronti del cristianesimo. La salvezza d'Israele è perfettamente indifferente alla storia cristiana - intesa come storia della salvezza. L'ebraismo sta 'accanto' al cristianesimo, senza esserne minimamente trasformato o condizionato: il dogma dell'ostilità ebraica, è davvero esclusivamente cristiano, poiché in toto subìto dalla storia della salvezza del cristianesimo." (p. 140). Solo attraverso questa radicalizzazione ulteriore si potrà affermare un'interpretazione dell'ebraismo che si collochi su nuovi binari rispetto alla sottomissione di cui ancora c'è traccia (e Petrarca non si sottrae al problema) negli scritti hegeliani. Un modo, insomma, di osservare l'ebraismo non più dall'Europa, ma da Israele.
Davide Assael
| |