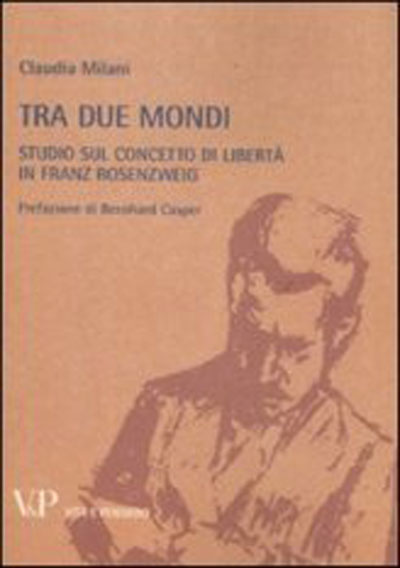Recensioni
Tra due mondi. Studio sul concetto di libertà in Franz Rosenzweig
| Autore | Claudia Milani |
| Genere | saggio |
| Area | Attività Scientifica |
| Casa editrice | Vita e pensiero |
| Anno | 2011 |
La promulgazione sul Sinai degli asheret devarim, le dieci Parole – meglio note come decalogo – rappresenta l’evento fondante del popolo ebraico. Fondante, poiché la promulgazione della Torah costituisce il sigillo del patto del Dio del Nome con il popolo d’Israele. Parlando di queste dieci Parole, il libro dell’Esodo spiega che esse erano «incise (charut) su tavola». I cosiddetti ‘comandamenti’ erano mitswot, precetti incisi nella pietra delle tavole, a rimarcare così la loro inscalfibilità, il loro carattere normativo. Non fosse che il Talmud, allontanando qualsiasi lettura legalistica, spiega: «non leggere charut (incise) ma cherut (libertà)». Quale significato può avere una simile libertà su pietra? Una libertà che non consiste nell’affrancamento da ogni precetto, ma che passa proprio dal precetto, libertà, dunque, nel comando, nella mitswà? Da questa problematica sorge la riflessione del filosofo ebreo-tedesco Franz Rosenzweig (1886-1929) sulla spinosa questione della libertà, intorno alla quale il denso e molto puntuale lavoro di Claudia Milani, Tra due mondi. Studio sul concetto di libertà in Franz Rosenzweig (Vita e Pensiero, 2011), come già anticipato nel sottotitolo, intende gettare luce, vista anche la carenza di studi specifici sul tema. Il libro, che ripercorre nell’impostazione la partizione delle prime due parti della Stella della redenzione soffermandosi poi con maggiore attenzione sulla Parte seconda, si apre con una dettagliata analisi dei nessi che Rosenzweig istituisce tra gli elementi del pre-mondo irrelato. Analisi molto utile e mai superflua, soprattutto per i “non iniziati” alla lettura del capolavoro di Rosenzweig che, ad un primo approccio, rischia di dissuadere anche i lettori più temerari. La critica a quella totalità che aveva trovato nel pensiero hegeliano il proprio massimo compimento, la critica a quella filosofia che «dalla Ionia e Jena» aveva preteso di pensare la specificità dell’esistente all’intero dell’orizzonte di comprensione della totalità, sortisce in Rosenzweig la rottura di questa stessa totalità. Da questa rottura, da questa krisis costitutiva della totalità hegeliana ‘sorgono’ quelli che Rosenzweig denomina gli elementi del pre-mondo: Dio, uomo, mondo. Elementi irrelati, tre monadi isolate delle quali Claudia Milani sottolinea e rimarca – a ragione – il carattere unicamente potenziale e irreale. Libertà nel pre-mondo è intesa come potenzialità di essere e di non essere che non dischiude alcuno spazio dell’agire pratico. E’ nella Parte seconda che la libertà diviene qualcosa di reale, quella libertà che si dischiude nel ‘logica’ relazionale della rivelazione. Milani insiste su un punto che sviluppa e articola sotto varie angolature: libertà, in Rosenzweig, è relazione, o meglio: è relazionalità; libertà di Dio di porre la relazione, libertà dell’uomo di accogliere la chiamata di Dio all’interno di quella relazione. Perciò, solo all’interno del rapporto Dio-uomo istituito dalla rivelazione è possibile concepire uno spazio per la libertà. Su questo aspetto, che costituisce senza dubbio il cuore dell’intero lavoro, Claudia Milani così scrive in conclusione: «[…] ponendo l’uomo al di fuori di sé, creandolo e poi rivelandoglisi, Dio lo istituisce come partner libero in un rapporto a due in cui la libertà di entrambi è chiamata seriamente in causa. Se Dio aveva giocato la sua libertà nell’istituzione del rapporto, l’uomo la gioca nella risposta data a Dio e lo fa in modo assai radicale […]. Il quadro che si delinea è allora quello di un uomo la cui libertà è adempiuta nella relazione, poiché autonomia ed eteronomia risultano inseparabili, e di un Dio che ha scelto di fare un passo indietro di fronte alla libertà della creatura […]. La libertà va quindi presa decisamente sul serio nell’orizzonte rosenzweighiano, perché rappresenta la garanzia del rapporto autentico tra uomo e Dio, dell’adultità dell’uomo e della modernità di un pensiero che ha fatto di Dio uno dei suoi temi cardine, ponendo però al centro l’autolimitazione della sua onnipotenza». Quale sarà allora il senso di questa libertà? Quale sarà il senso di questa relazione del tutto ‘asimmetrica’ che pone la libertà? Una libertà davvero in toto affidata alla relazione con l’Altro, al punto da poterne anche essere ‘minacciata’ – se non altro, dall’insecuritas in cui la relazione con (e del) l’Altro la pone? Libero sarà dunque, quell’atto che saprà farsi capace di sostenere in sé non solo la pulsione alla propria libertà, ma anche l’abisso ch’essa apre ad ogni passo? Libertà non dal precetto, ma libertà nel precetto, nella relazione dove però – in forma del tutto paradossale – non è il precetto a garantire l’atto libero, ma propriamente il contrario, se di quella stessa libertà – certo tutta umana e finita – si vuole mantenere la possibilità? Non leggere charut, dunque, leggi cherut.
Giacomo Petrarca
| |