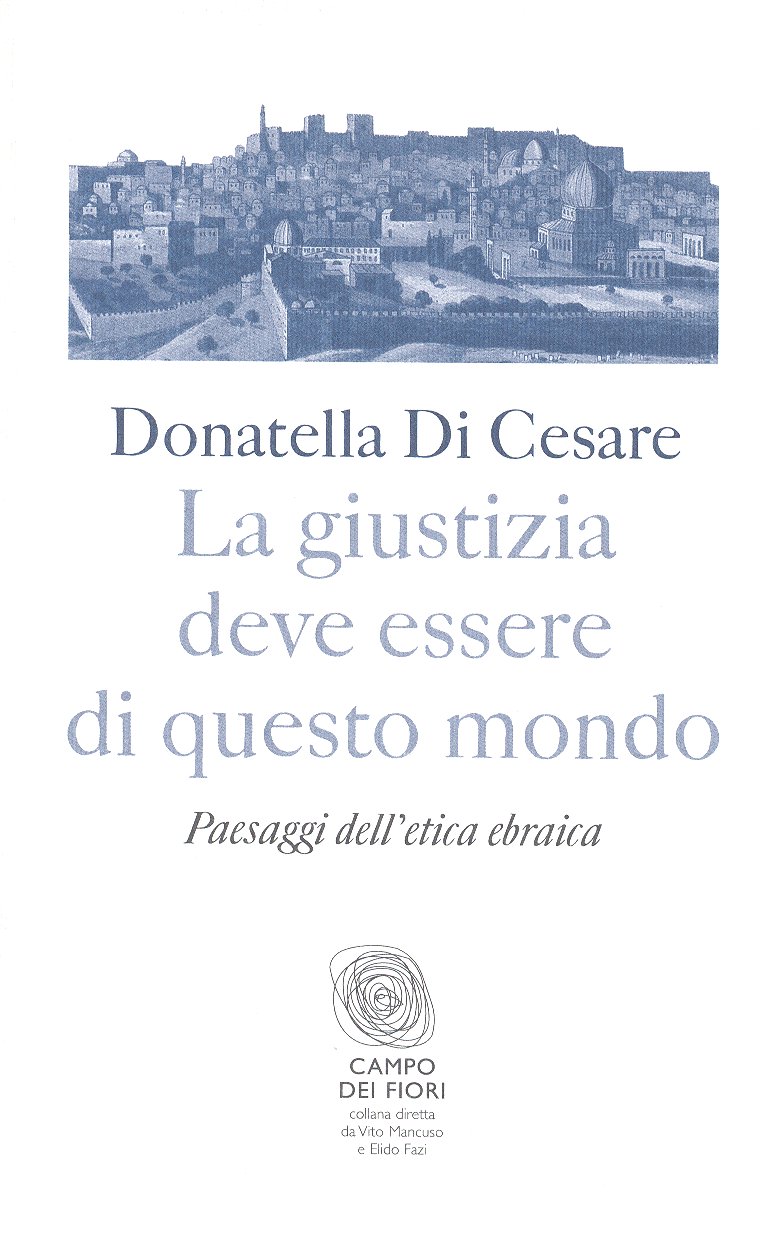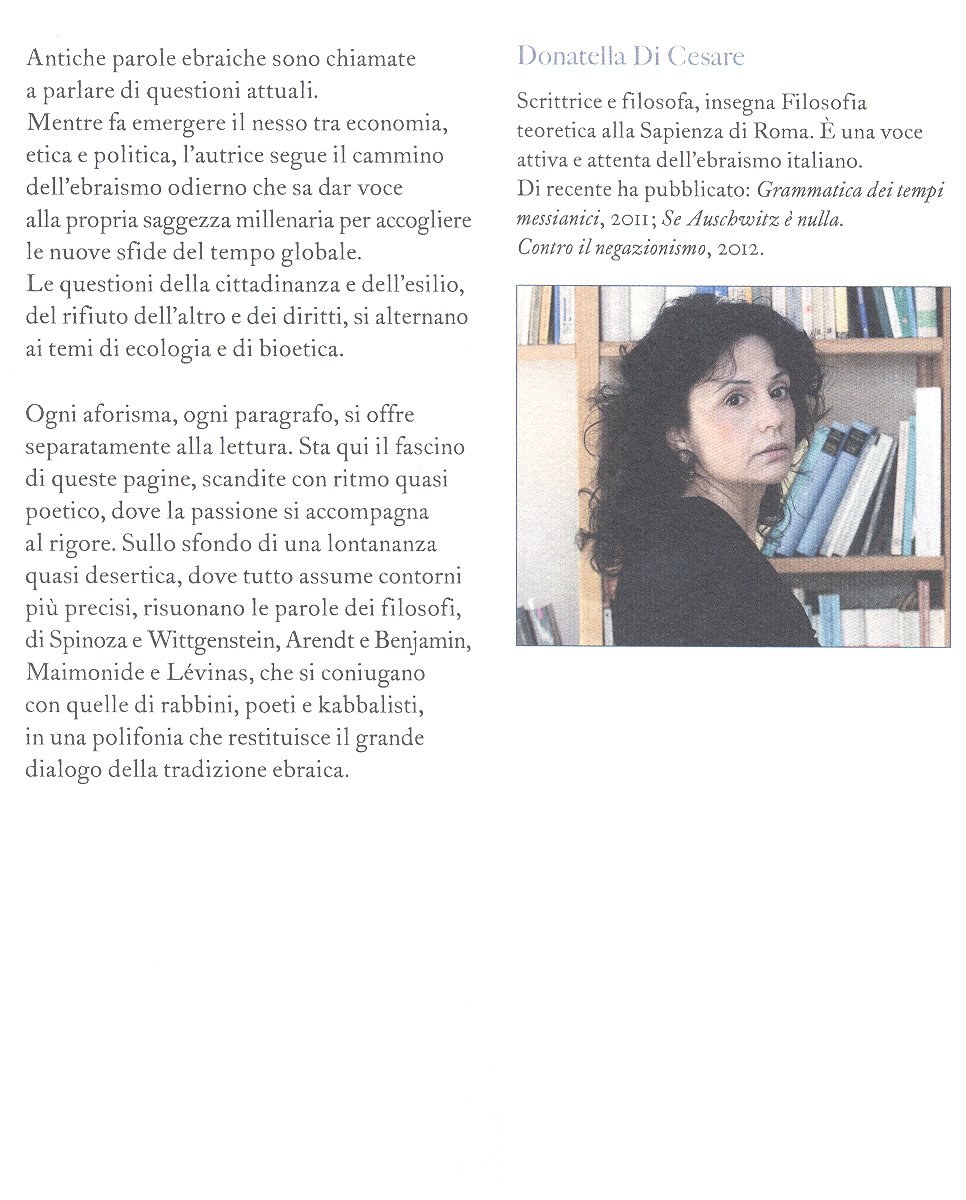Recensioni
La giustizia deve essere di questo mondo. Paesaggi dell’etica ebraica
| Autore | Donatella Di Cesare |
| Genere | saggio |
| Area | Attività Scientifica |
| Casa editrice | Fazi Editore |
| Anno | 2012 |
| Biblioteca | Visualizza la scheda del libro |
Come noto, l’ebraismo è anzitutto un’ortoprassi, un modo pratico di condurre la vita. E proprio per questa sua ricaduta sul pratico, l’ebreo è colui che si differenzia dagli altri, vivendo chiuso in una prassi comunitaria, che sembra creare un solco incolmabile col mondo circostante. L’ebreo è colui che non mangia come gli altri, che veste in modo differente, che vive un tempo diverso. Un’interpretazione riduzionistica dell’etica ebraica smentita da questo libro di Donatella Di Cesare, filosofa romana che da tempo conduce una riflessione a cavallo fra categorie ebraiche e filosofiche nel solco della miglior tradizione levinassiana. L’analisi di Di Cesare restituisce dignità teorica all’ebraismo, mostrando come la sua pratica sia portatrice di una visione coerente, che, piuttosto che smentire l’ideale di un’uguaglianza di tutti gli individui, come spesso le viene rimproverato, chiede che si concretizzi in un piano normativo ed in dei confini geografici, senza i quali si disperderebbe al vento. Un approccio che contrasta con quel “sogno dell’illimitato”, che, ci ricorda l’autrice, sembra caratterizzare l’attuale società globalizzata, dove sotto mentite spoglie si nasconde un progetto egemonico di una cultura su tutte le altre. Ridando dignità allo sfondo etico ebraico, l’autrice riesce a ricostruire anche il senso di quella pratica che sembrava solo il segno di un particolarismo esasperato. Azioni come il rispetto del Sabato, il giorno del riposo, o la Tzedakàh, termine impropriamente tradotto con “elemosina”, hanno un valore politico, come tentativo di preparare una società dove non abbia corso la dialettica del servo e del signore di hegeliana memoria. Non, dunque, segno di chiusura e separazione, ma di apertura alla dignità di tutti gli individui, “della vedova, dell’orfano…” e di tutti gli esclusi. Sentiamo l’autrice: «La rivoluzione è evento che irrompe, improvviso e imprevedibile, qui e ora. A ogni Shabbat, nel ricordo dell’uscita dall’Egitto (zecher leietzia’at Mitzraim), il popolo ebraico ri-vive la liberazione. Il Dio di Israele spinge alla rivolta, all’esodo. E questa rivoluzione, che ricorre ogni Shabbat, e viene potenziandosi secondo il ritmo del sette, fino all’anno dello Yovèl, in cui le terre saranno restituite, i debiti rimessi, gli schiavi liberati, non potrà essere se non una “rivoluzione permanente” […] Per Israele la rivoluzione è concepita come costituzione, la costituzione come rivoluzione». L’insofferenza occidentale verso l’ebraismo nasce proprio da qui, dalla sua capacità di fare da argine ad un progetto assimilazionistico, dall’autrice ricondotto ad una matrice cristiana, che pratica la relazione fra differenze come una redutio ad unum. Questo è anche l’aspetto più universale del particolarismo ebraico: un’etica del limite non contrasta gli ideali universalistici, semmai si offre come imprescindibile momento di concretizzazione, perché, come recita il titolo del libro, “La giustizia deve essere di questo mondo”. Un messaggio ancor più forte in un mondo che spesso “esporta” i propri valori universali con le armi.
Davide Assael
| |