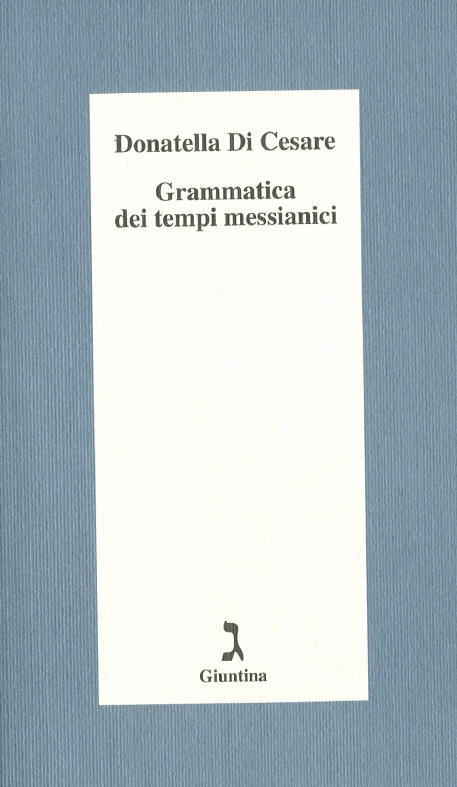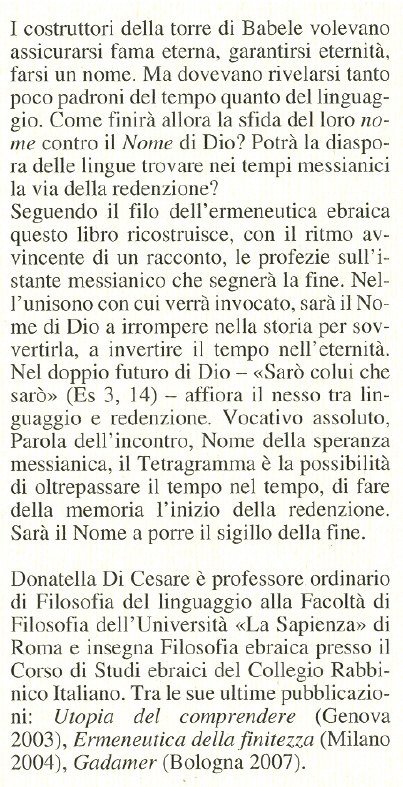Recensioni
Grammatica dei tempi messianici
| Autore | Donatella Di Cesare |
| Genere | saggio filosofico |
| Area | Attività Scientifica |
| Casa editrice | Giuntina |
| Anno | 2011 |
| Biblioteca | Visualizza la scheda del libro |
La tradizione ebraica è tradizione della parola. Davar, in ebraico, significa appunto ‘parola’. Ma ‘parola’ è anche cosa, evento, accadimento. La creazione genesiaca non è, quindi, solo scandita dalla parola, ma ne è essenzialmente costituita. Il ‘dono’ della Torah sul Sinai salda ‘poi’ questo nesso, indicando quell’orizzonte all’interno del quale la sradicatezza del popolo d’Israele trova il proprio ethos, la propria dimora: il Libro. La tradizione talmudica da un lato, e quella cabbalistica dall’altro, non fanno che ribadire la centralità di questo rapporto con il Libro essendone la continua ‘ripetizione’ (mishnà), l’incessante commento, come recita il trattato ‘Avot: «hafok vah wehafok bah dekola’ bah - girala e rigirala, perché in essa c’è tutto» (Pirqè ‘Avot, cap. V). È all’interno di questo orizzonte che si colloca l’intenso libro di Donatella Di Cesare, Grammatica dei tempi messianici (Giuntina 2011, disponibile anche in francese presso l’editore Hermann): si colloca, nel senso che ne assume, dal profondo, tutta la portata problematica, interrogandolo e facendosene interrogare. Se Utopia del comprendere (Il Melangolo 2003) ‘indicava’ il luogo-non-luogo al quale l’operazione ermeneutica si volge e in cui essa articola il proprio ou-topico ‘conoscere’ (se è proprio quel luogo ad essere prodotto, ogni volta, dal commento e insieme, a costituire la condizione di possibilità perché commento possa darsi – in questo la sua “utopicità”), Grammatica dei tempi messianici fa dell’“impossibile” esperienza di quell’ou-topicità il suo tratto costitutivo: la confusione delle lingue, la confusione babelica, diventa l’evento che spezza l’unità della lingua, spezza l’unità della ‘parola’ e la con-fonde. Spezza un’unità proprio a causa – e questo è un punto essenziale del libro – del tentativo da parte degli abitati di Babel di perseguire l’unità, l’unità del Nome (“facciamoci un nome”, è infatti il loro proposito – proposito che Di Cesare analizza nelle prime pagine del libro, ricorrendo a tutta una serie di commenti della tradizione ebraica che ne chiarificano il significato troppo spesso frettolosamente identificato come hybris contro la divinità, senza poi comprendere in che cosa questa hybris consista; infatti – spiega Di Cesare – il farsi un nome e la costruzione della torre non sono immediatamente sovrapponibili). E proprio da quella rottura, da quella frattura che disperde la parola in innumerevoli frammenti, si costituisce il senso – ben prima dell’esigenza – del gesto messianico: la redenzione. Una redenzione che passa attraverso le tracce di quella lingua, attraverso il senso stesso dell’esilio: ché prima di cancellarlo, ne esperisce completamente la condizione di erranza. Il linguaggio diventa così il luogo d’espressione massima della temporalità, una temporalità in toto piegata nell’ora, nell’Adesso, in cui s’incontrano-scontrano le due tensioni del gesto messianico: quello dell’attesa e quello dell’anticipazione. E Grammatica dei tempi messianici – lungi dal nascondere questa difficoltà – ne persegue l’istanza e la portata problematica, conducendole fino all’estremo; è questo il caso delle dense pagine dedicate all’analisi del significato del Tetragramma divino e della temporalità che ad esso sottende, dove nell’intraducibile struttura del doppio futuro del verbo essere contenuto nel nome di Dio – “Ehjeh Asher Ehjeh” – (Es 3,14) si esprime una paradossale sincronia: paradossale, poiché non cancella, non consuma quella tensione tra il divieto talmudico di qualsivoglia discorso sulla fine e l’invito costante ad affrettare la venuta del Messia (del resto, tale cancellazione significherebbe la massima affermazione del proposito babelico!). Scrive Di Cesare: «la sincronia di passato, presente e futuro, inscritta nelle consonanti del Tetragramma, non designa una co-presenza in Dio di tre tempi che costituirebbe una eternità astratta – come quella intesa nella traduzione “l'Eterno”. Nel Tetragramma il tempo non è per nulla abolito; piuttosto contratto. In questa contrazione il passato più antico e il futuro più lontano si incontrano nell'istante presente in cui irrompe l'eternità. Solo così il “Dio dei vostri padri”, il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, nel suo divenire sul filo della storia, può annunciare l'insurrezione dell'esodo, il compimento dei sogni più utopici del popolo ebraico. [...] Il Tetragramma è la possibilità di oltrepassare il tempo all'interno del tempo, di fare della memoria l'inizio della redenzione». Resta certo la questione, tutta filosofica, del significato di quel discorso che intenda parlare di questa redenzione se, proprio l’uscita dall’esilio è detta, è narrata con la lingua dell’esilio. Difficoltà, dalla quale neppure Grammatica dei tempi messianici può essere esente, se proprio la lingua della quale intende ‘definire’ l’uso e l’applicazione (appunto: gramma-tiké) è la lingua che per eccellenza non può essere definita, lingua della ‘pura’ novitas, lingua in-condizionata rispetto ad ogni definizione o condizione. In questo senso, Grammatica dei tempi messianici delinea anche la possibilità d’un differente significato di grammatica: una grammatica che nell’attesa del senso, del proprio compimento, nell’attesa della ‘propria’ lingua, parli – anche – le lingue degli altri, le lingue dell’esilio, facendosi così grammatica di tutte le lingue, senza però possederle, né performarle – proprio perché a nessuna di quelle lingue essa appartiene. Una redenzione, dunque, dalla pluralità babelica delle lingue all’interno di questa stessa pluralità, in attesa del giorno in cui Egli darà «ai popoli labbra pure» ed «Egli sarà Uno ed il Suo nome sarà: Uno» (Zc, 14.9).
Giacomo Petrarca
| |